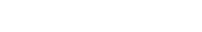Ci continuiamo a ripetere che per un’infanzia felice, sana ed equilibrata serve un villaggio. Che la famiglia (di qualunque tipo essa sia) da sola non basta. Ma esiste un villaggio, in Italia? Ci sono i servizi pubblici, la sensibilità e la cultura necessari per accogliere le esigenze delle persone più piccole senza mortificare genitori spesso esausti e senza alcun appiglio?
La risposta oggi è NO.
Vediamo come la genitorialità in Italia sia ancora ingabbiata all’interno di ruoli tradizionali, con altrettante tradizionali disuguaglianze e discriminazioni. La famiglia tradizionale composta da uomo e donna, con la negazione di genitorialità altre. La visione deterministica e naturale del ruolo di cura della donna, angelo del focolare destinata a dover sacrificare diritti, spazi di socialità, autodeterminazione. La visione patriarcale dell’uomo padre e padrone, colui che ha il potere, economico e non solo, anche lui determinato naturalmente a non partecipare alla cura della famiglia. Tutti questi ruoli imposti culturalmente e spesso anche legalmente o burocraticamente, tarpando le ali a una società che cambia. E lo fa in meglio, perché se i diritti si estendono a tutte, tutti, tuttɜ, allora non rimangono privilegi. E avremo famiglie, comunità, villaggi felici.
Ad oggi, gli strumenti messi a disposizione attraverso le politiche della famiglia (una, tradizionale) – dalle varie forme di congedo ai sussidi alla flessibilità degli orari di lavoro, ai posti negli asili nido – sono di fatto insufficienti per rispondere alle esigenze delle famiglie. Inadeguati per garantire condizioni di parità tra i genitori. Incompleti per far fronte ai bisogni medici di madre e bambinə. Assenti per fornire momenti di svago e accompagnare ə bambinə nella sua crescita personale.
Il luogo di nascita, insieme al contesto socio economico, pesano ancora in maniera determinante sulle possibilità di unə bambinə di ricevere le cure necessarie, di avere un’alimentazione equilibrata, di partecipare ad attività ricreative e culturali, di accedere agli studi superiori, di inserirsi nel mondo del lavoro.
In una società che invecchia, in cui sempre più spesso per lavorare e costruirsi un futuro si è costretti a spostarsi lontano dal luogo di origine, lontano dai propri riferimenti, dalla famiglia e dai legami sociali, la carenza di servizi di sostegno alle famiglie, non fa altro che accentuare le disuguaglianze. A farne le spese sono le famiglie più povere, migranti e genitori single.
Al di là del contesto socioeconomico, nel panorama generale sono ancora soprattutto le donne a farsi carico della gestione familiare mettendo in secondo piano la vita professionale e sociale.
Non è vero che si può “avere tutto”, di certo non lo è per tuttɜ. Soprattutto nei primi anni di vita del bambinə, ma anche dopo, chi non ha le spalle coperte è spesso costrettə a fare delle scelte che inevitabilmente avranno un impatto in termini di reddito, di esclusione dalla partecipazione alla vita sociale, associativa e politica. Oltre all’aspetto materiale, le ripercussioni toccano anche la salute fisica e mentale dei genitori. In particolare la salute delle donne, grande assente sia in medicina, che in politica e in società.
Sostenere le famiglie, ogni tipo di famiglia, a partire dai primi giorni della nascita del bambinə, è una responsabilità che lo Stato e gli enti locali competenti devono assumere pienamente per garantire il rispetto del principio di uguaglianza nell’intero territorio. Sostenere le famiglie vuol dire investire nel futuro della società di domani e riconoscere la libertà delle persone oggi. La libertà di scegliere se, quando, come e con chi crearsi una famiglia senza paura.
Le soluzioni esistono, ma dobbiamo far emergere la volontà politica di portarle avanti.
Nei cruciali “primi 1000 giorni”, i genitori e poi ə neonatə, devono avere la possibilità di far ricorso a personale sanitario e medico-sociale specializzato. In particolare, nella fase post parto, nessuna madre dovrebbe essere lasciata da sola. Servono servizi a domicilio mirati e pluridisciplinari, per fornire il supporto necessario alle famiglie. Chi sceglie di allattare, deve poter disporre di spazi e condizioni adeguate anche sul posto di lavoro.
Nessunə dovrebbe essere costretto a lasciare il lavoro per occuparsi deɜ figliɜ per sopperire alle carenze di asili nido; il congedo maternità e paternità — che ci piacerebbe diventasse, nel linguaggio e nella sostanza, un congedo di genitorialità — deve essere esteso e prolungato e avere uguale durata per i genitori, uscendo anche dalle logiche che legano questo diritto solo a chi ha un lavoro da dipendente. Chi torna a lavoro o intraprende la ricerca di un impiego dopo il congedo di genitorialità non deve essere penalizzato dal datore di lavoro né dal punto di vista materiale che da quello gerarchico. La flessibilità degli orari di lavoro e il ricorso allo smart working per i genitori (e non solo!) permettono di garantire una continuità nel percorso lavorativo, favorendo il giusto equilibrio tra vita privata e professionale. In quanto tali, devono essere promossi a tutti i livelli, e non stigmatizzati.
Rendere i trasporti pubblici accessibili, ripensare la mobilità incentivando quella dolce e creare aree di gioco all’aperto e ludoteche, organizzare spazi di gioco nei luoghi pubblici istituzionali (e.g. sale di aspetto negli uffici pubblici, negli ospedali), ricreativi e culturali (e.g. bar, ristoranti, hotel, musei, librerie), significa includere le famiglie nella vita della società. E significa creare un Paese a misura delle persone.
Le politiche della famiglia, se ben concepite e volte all’equità di genere e all’uguaglianza sociale, possono costituire la spina dorsale del welfare state, quindi del benessere della nostra società.
Cosa ne pensate?
Attraverso il questionario online, vi proponiamo di condividere la vostra esperienza personale per aiutarci ad arricchire la riflessione sul tema e trarre spunto per costruire insieme le soluzioni possibili.