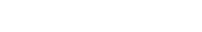Secondo le stime più recenti dell’OCSE, l’Italia rimane uno dei paesi con le condizioni abitative più compromesse della regione con tassi di sovraffollamento e i costi più alti e penalizzanti per le famiglie a basso reddito, moltiplicando le disuguaglianze: il 32% degli inquilini più fragili spende più del 40% del proprio reddito in affitto e il 49% dei proprietari a basso reddito hanno un mutuo le cui rate mensili superano il 40% del reddito.
650 000 famiglie sono nelle graduatorie comunali per l’accesso ad una casa popolare (circa 1,4 milioni di persone).
Ogni anno vengono emesse tra le 40.000 e le 50.000 sentenze di sfratto che coinvolgono almeno 120.000 persone di cui almeno 30.000 minori.
A fronte di questa situazione, la realizzazione del diritto all’abitare come asse portante di equità, dignità, salute, inclusione, autonomia e sicurezza, richiede lo sviluppo di politiche, piani di attuazioni e di monitoraggio integrati e a lungo termine, che vadano oltre l’affrontare le carenze del mercato abitativo, le “lacune” e le crisi di prezzo degli alloggi.
Politiche abitative efficaci sviluppano quadri strategici che riconoscono la funzione sociale della casa, che non può essere subordinata al profitto, come una risposta a un diritto riconosciuto e il ruolo centrale dell’intervento pubblico per raggiungere obiettivi per di giustizia sociale e riduzione delle disuguaglianze.
Mappatura
Per strutturare una politica pubblica dell’abitare in grado di dare risposta all’esclusione e al disagio abitativo, è necessaria innanzitutto una mappatura e analisi in grado di chiarire non solo la domanda abitativa, ma soprattutto lo stato delle unità vuote e sfitte (sia pubbliche che private) che potrebbero essere rimesse in circolo.
La creazione di Osservatori Locali, collegati al nuovo Osservatorio Nazionale della Condizione Abitativa, che mettano in rete tutti i differenti attori risulta quindi cruciale per rilevare in tempo reale i bisogni abitativi, monitorare le barriere d’accesso e analizzare la situazione del parco immobiliare, nonché valutare l’impatto delle misure intraprese per affinare l’azione politica.
Un esempio interessante di mappatura e raccolta dati sulle case sfitte viene dalla città greca di Salonicco, dove gli archivi del gestore della rete di distribuzione elettrica sono stati utilizzati per analizzare le disconnessioni di energia elettrica con precedente uso residenziale.
Ancora, nel 2021, il ministro francese delle politiche abitative ha presentato un nuovo programma pilota nazionale, aperto a 68 autorità regionali, per facilitare l’identificazione degli alloggi sfitti attraverso un nuovo software: “Zéro Logement Vacant”. Questo strumento digitale si basa su dati nazionali ricavati dalle banche dati fiscali e immobiliari per identificare le abitazioni sfitte. I proprietari possono inoltre capire se il bene è soggetto al pagamento della tassa sugli alloggi sfitti (introdotta per le zone con alti squilibri tra domanda e offerta) e prendere contatto con la collettività per rimettere il bene sul mercato.
Recupero e rimessa in circolo di patrimonio inutilizzato
Attraverso azioni rivolte al recupero del patrimonio privato inutilizzato — vuoto o sfitto — si possono raggiungere diversi obiettivi tra cui la riattivazione di un’importante offerta per i nuclei abitativi più fragili, rispondere alle difficoltà dei proprietari, contrastare il consumo di suolo limitando la costruzione di nuovi edifici, ed evitare condizioni di degrado e mancanza di sicurezza che possono derivare dalla presenza di alloggi vuoti.
Questo può avvenire incentivando e facilitando la cessione degli immobili vuoti in regime di affitto concordato e garantito ai Comuni (come nel caso di Barcellona, Strasburgo, Lisbona, Emilia Romagna), i quali procedono alla redistribuzione degli immobili secondo criteri di necessità e urgenza.
In parallelo si può agire attraverso la leva della fiscalità, come in molti altri paesi, rendendo oneroso il mancato utilizzo degli immobili di cui i proprietari sono in possesso.
Introdotta nel 1998, per esempio, la tassa sulle case sfitte in Francia si applica a tutti gli alloggi abitabili che sono rimasti sfitti per più di un anno. L’imposta viene calcolata sulla base del potenziale affitto annuale che l’immobile potrebbe produrre, inizialmente a un tasso del 12.5% del valore dell’affitto durante il primo anno fino al 25% dopo quattro anni di sfitto.
Nel 2023 i due tassi sono stati aggiornati passando rispettivamente al 17% e 34%.
Effetto Airbnb
Gli affitti di breve termine agiscono sul mercato immobiliare diminuendo l’offerta abitativa locale a lungo termine, aumentando i prezzi e innescando la fuga degli abitanti che spesso non hanno i mezzi per contrastare, da soli, questa tendenza.
Se questo problema è maggiormente sentito nelle grandi città, ormai il fenomeno interessa anche i piccoli centri storici e i luoghi –cosiddetti- di villeggiatura. In quest’ultimo caso s’ignorano completamente i bisogni dei residenti, che faticano a trovare un’abitazione permanente perché la disponibilità abitativa è limitata al solo periodo, per esempio, invernale.
Questo fenomeno impoverisce inoltre il tessuto urbano e sociale; i quartieri si trasformano rapidamente per adeguarsi a questa nuova forma del (non) abitare, con sempre meno servizi per i cittadini e gli equilibri stravolti a profitto del turismo di massa.
In questa dinamica subentra poi un problema parallelo: le piattaforme di affitto di corta durata sono spesso utilizzate per nascondere vere e proprie attività commerciali su larga scala ed evitare di pagare la tassazione corrispondente ad un’attività di tipo ricettivo-turistica.
Alcune città hanno però cominciato a disciplinare gli affitti brevi :
Ad Amsterdam, in tre dei quartieri dove il mercato immobiliare è più teso, non è permesso affittare interi alloggi su Booking e Airbnb, ma solo stanze in abitazioni dove il proprietario deve dimostrare di essere residente
A San Francisco, qualora si voglia affittare per brevi periodi il proprio appartamento, è necessario registrarsi presso il Comune e dimostrare di risiedere nell’appartamento per almeno 275 giorni all’anno.
Case popolari
La gestione delle residenze pubbliche e sociali presenta note fragilità legate alle tempistiche di assegnazione delle case, alla gestione di manutenzioni e al controllo degli immobili vuoti. A fronte di 650 mila famiglie nelle graduatorie comunali per l’accesso ad una casa popolare (circa 1,4 milioni di persone), almeno 48.000 case popolari rimangono non utilizzate per mancata manutenzione. Questo è dovuto da un lato alla segmentazione tra enti proprietari e vari enti di gestione, nonché alla mancanza di un sostegno economico di carattere strutturale ma basato quasi esclusivamente sull’auto-sostenibilità.
Vienna ha istituito un contributo per l’edilizia abitativa nell’ambito dell’imposta federale sul reddito (0,5% sia per i datori di lavoro che per i dipendenti) con il quale vengono raccolti circa 250 milioni all’anno per il parco abitativo pubblico. Inoltre, dal momento che l’azione pubblica per l’accesso alla casa segue un modello tradizionalmente universalista e fondata sull’obiettivo dell’integrazione sociale (l’80% dei nuclei familiari rientra nei limiti di reddito per accedervi), questo ha permesso un sistema di segmentazione equo dei canoni dove gli inquilini più abbienti coprono parte dei costi dei nuclei abitativi più fragili.
In Olanda, Aedes, la federazione nazionale gestori di alloggi sociali, che riunisce 310 fornitori locali, svolge annualmente un accurato processo di “benchmarking” per monitorare le prestazioni dei suoi membri. Questo processo di benchmarking comprende un’analisi dettagliata della soddisfazione degli inquilini, delle spese operative, della sostenibilità ambientale, della manutenzione e delle ristrutturazioni, della disponibilità, dell’accessibilità economica e delle nuove costruzioni. Il benchmark è fondamentale per il funzionamento efficace del settore dell’edilizia sociale; fornisce ad Aedes informazioni per supportare i decisori politici a migliorare le politiche e gli interventi di settore. Inoltre, consente di controllare la qualità dell’operato dei singoli fornitori e di identificare quelli che faticano a raggiungere gli obiettivi.
Nel 2012 il governo scozzese ha istituito lo Scottish Social Housing Charter, una serie di risultati e standard per tutti i gestori di alloggi sociali. Lo Scottish Housing Regulator (SHR) misura le prestazioni dei gestori rispetto a tali standard.
Dismissione e Pianificazione
Negli ultimi anni, diverse città italiane hanno dismesso, ripetendo il mantra della rigenerazione urbana, parti importanti del loro patrimonio — soprattutto fondiario — a privati (compagnie, fondi d’investimento), senza regolamentarne l’utilizzo e a discapito del bene comune.
Questa scelta è spesso fatta unicamente per reperire risorse finanziarie e svincolarsi dal peso della gestione del parco immobiliare, senza però prendere in considerazione le incalcolabili conseguenze negative sulla società e sulle condizioni di moltissime famiglie che vivono in condizioni abitative precarie.
Oltretutto, gli immobili vengono spesso “svenduti”, andando di fatto a creare uno scenario disgregativo sulla comunità : da una parte le amministrazioni non riescono a fare cassa in maniera adeguata per ripagare il debito pubblico o finanziare programmi strutturali nelle città, e dall’altra le società private che acquistano i beni lo fanno per pure ragioni di profitto, senza avere lo scopo di apportare un progresso per una forma di abitare più equa. In sostanza, c’è il rischio che la comunità si ritrovi sempre più demunita dei proprio mezzi, incrementando gli squilibri già in atto.
La pianificazione territoriale è uno strumento che può essere utilizzato per richiedere o incoraggiare la fornitura di alloggi a prezzi accessibili.
Lo strumento dell’inclusive zoning può catturare risorse dal mercato privato per il settore dell’edilizia sociale e a prezzi accessibili. Ciò avviene attraverso l’inclusione obbligatoria o volontaria di specifiche tipologie di alloggi a prezzi accessibili come condizione per l’approvazione della pianificazione di nuove costruzioni abitative.
In un contesto europeo, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito hanno adottato una qualche forma di inclusive zoning negli ultimi decenni.
In Francia l’edilizia sociale è gestita da enti locali, organizzazioni non profit o partenariati pubblico-privato. La legge SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain — Soldarietà e Rinnovamento Urbano), approvata nel 2000, originariamente richiedeva che la maggior parte dei comuni urbani garantisse che almeno il 20% del loro patrimonio abitativo complessivo fosse di edilizia popolare entro il 2020. Nel 2013 l’obiettivo è stato aumentato per arrivare al 25% entro il 2025.
Questa legge punta a riequilibrare l’offerta di alloggi sociali sul territorio intorno al tema della “mixité sociale”, ossia la convivenza di persone di diversa estrazione sociale.
Nel Regno Unito, le due principali fonti di investimento in nuovi alloggi sociali sono costituite dal finanziamento del governo centrale e dagli accordi di pianificazione tra sviluppatori privati e autorità locali, in base ai quali lo sviluppatore contribuisce con terreni, alloggi o denaro come condizione per il permesso di costruzione.
Gli accordi di pianificazione devono essere direttamente pertinenti allo sviluppo proposto, prescrivere una determinata porzione di alloggi a prezzi accessibili e compensare la perdita o il danno creato da uno dato programma (ad esempio, perdita di spazio aperto) o mitigare l’impatto dell’operazione (ad esempio, attraverso un aumento servizio di trasporto pubblico).
Fuori sede
Sebbene nella maggior parte dei Paesi OCSE, la maggioranza dei giovani tra i 20 e i 29 anni viva con i genitori, la quota è ben più alta in Italia (74%) e la tendenza in continua crescita. Ciò si riflette anche nell’età media in cui i giovani lasciano il nucleo familiare dei genitori, oltre i 30 anni. I dati dell’Eurostudent Database registrano anche in Italia uno dei tassi più bassi di studenti che seguono un’istruzione superiore e hanno accesso a un alloggio per studenti — solo il 10%, rispetto al 30% in Paesi Bassi e Svezia.
Il lungo periodo di istruzione, l’insicurezza del mercato del lavoro e l’accesso più ristretto al credito, fanno sì che molti giovani si rivolgano sempre più spesso a soluzioni di affitto. L’aumento del costo degli affitti, a sua volta, impedisce ai giovani di risparmiare per garantire un deposito, necessario per poter ottenere un mutuo senza l’aiuto dei genitori. Fatto che crea maggior ineguaglianza.
Poiché per i giovani è sempre più difficile ottenere la proprietà di una casa, le cooperative edilizie, cooperative, i community land trust e altre iniziative di collaborazione possono rappresentare un buon passo avanti nella “scala abitativa”, che sia accessibile e di proprietà e gestione collettiva.
In una città in cui l’affitto mensile può facilmente superare i 1.500 euro e il costo complessivo della vita è tra i più alti al mondo, le alternative abitative a prezzi accessibili sono fondamentali, anche per gli studenti. Le cooperative sociali si stanno rafforzando a Ginevra e questo progetto di alloggi per studenti in Place des Volontaires a Coulouvrenière ne è un esempio. Il progetto è stato sviluppato con un processo partecipativo che ha coinvolto una cooperativa di alloggi per studenti e gli stessi futuri occupanti. L’affitto mensile è di circa 250 franchi svizzeri (230 euro). L’idea è che, al momento del trasferimento, gli studenti acquistino una quota della cooperativa a un prezzo non superiore al deposito dell’affitto. di un deposito per l’affitto, e quando si trasferiscono la vendono al successivo occupante dell’appartamento.
Allo stesso tempo, il governo dovrebbe regolamentare gli investimenti nelle strutture per studenti per proteggere il settore dalla finanziarizzazione che privilegia la rendita rispetto alla salute, al benessere, all’uguaglianza e alla dignità dei residenti. A questo proposito, gli Stati dovrebbero indirizzare qualsiasi sussidio a operatori senza scopo di lucro.
Discriminazioni
In un sistema abitativo squilibrato ed una risposta del servizio pubblico carente, si possono instaurare meccaniche discriminanti che precludono l’accesso alla casa a causa dell’origine, della religione o dell’orientamento sessuale di chi sta cercando un alloggio per costruirsi un futuro.
Senza un luogo sicuro, le condizioni di chi è già in difficoltà non possono far altro che peggiorare, andando ad aggravare le già precarie condizioni sociali di parti della comunità.
Nel caso dei rom, solo una piccola percentuale di quelli che vivono in Italia sono nomadi (circa il 3%), ma essendo etichettati nella stragrande maggioranza dei casi come tali, spesso le amministrazioni rispondono all’esigenza abitativa creando dei “campi attrezzati”, che altro non sono che l’emblema della ghettizzazione.
Le condizioni di vita insostenibili, il sovraffollamento e la negazione di accesso ai servizi pubblici di base diventano così ulteriore ostacolo per l’inclusione sociale.
In molti casi i rom, così come molti cittadini stranieri, vengono esclusi dal mondo del lavoro regolare che gli consentirebbe di accedere ad un affitto di mercato, e la casa popolare rimane spesso l’unica via per un alloggio decoroso.
La disponibilità di un’abitazione è poi uno dei requisiti previsti perché un cittadino straniero in Italia possa ottenere il permesso di soggiorno, un lavoro o richiedere il ricongiungimento familiare.
Prendendo come esempio quest’ultimo tema, sono purtroppo numerose le segnalazioni di famiglie straniere cui viene proposta come unica scelta la divisione del nucleo familiare: donne e bambini in una determinata struttura di accoglienza e uomini in un’altra.
Anche in questo caso la pianificazione ha un ruolo fondamentale per evitare la segregazione ed i conflitti sociali.
A Vienna è stato istituito un “Centro di coordinazione per i rifugiati” che funge da centro informazioni unico, in costante contatto con le compagnie dei trasporti, le forze di polizia, le organizzazioni non profit ed i cittadini volontari.
A Lione è stato firmando un accordo con l’associazione che si occupa di edilizia sociale che ha messo a disposizione 300 unità abitative all’anno in cambio di assistenza e supporto per i rifugiati alloggiati, affinché non siano semplicemente “collocati” in una casa, ma guidati verso l’autonomia e integrati nelle comunità.
Tutele
In Italia le famiglie in affitto sono circa il 20% delle famiglie residenti, ma rappresentano circa il 45% dei 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, di queste 1,3 milioni sono minori.
A fronte di numeri sempre crescenti di povertà nel nostro paese, la scelta di non rifinanziare il fondo di contributo per l’affitto e la morosità incolpevole rischia da aumentare il numero di sfratti e peggiorare una situazione abitativa già critica eliminando una fonte di assistenza per oltre 600 000 famiglie.
Inoltre, nonostante l’esistenza di norme internazionali a riguardo, nel caso di sfratti eseguiti con la forza pubblica (tra i 25 000 e 30 000 ogni anno che vedono coinvolti almeno 15 000 minori), quasi mai si assiste in un passaggio da casa a casa o sono presenti assistenti sociali o rappresentati dei Comuni.
A fronte di un numero crescente di persone in affitto, l’Italia dovrebbe dotarsi di meccanismi per migliorare la sostenibilità abitativa, come la determinazione di affitti equi e la loro indicizzazione, la partecipazione e contrattazione sindacale, il sostegno all’affitto.
In Germania, gli affittuari privati possono aderire a un’associazione di inquilini, chiamata Mieterbund o Mietervereine. Queste associazioni rappresentano gli interessi degli inquilini e offrono ai membri consulenza sui contratti di locazione, sui costi delle utenze e sulle leggi in materia di locazione. Il Deutscher Mieterbund (DMB) è un organismo nazionale che rappresenta 320 organizzazioni locali di inquilini in tutta la Germania. Gli inquilini pagano una piccola quota associativa e l’organizzazione impiega 1.300 dipendenti a tempo pieno e 2.500 volontari in tutta la sua rete. Molte associazioni di inquilini offrono anche una protezione contro i costi legali attraverso un’assicurazione di protezione legale. A tal fine, l’Associazione tedesca degli inquilini, le associazioni regionali e le associazioni locali di inquilini hanno fondato nel 1983 una propria compagnia assicurativa, la German Tenants’ Association Legal Protection Insurance AG.
Nel 2020, la città di Barcellona ha introdotto un nuovo sistema di determinazione degli affitti basato sul concetto di affitto di riferimento. Gli affitti dei contratti stipulati dopo il 1995 devono essere abbassati qualora siano superiori al livello di riferimento. La nuova legge copre anche le spese di servizio, ma non le abitazioni costruite negli ultimi tre anni né gli alloggi sociali. Sono previste multe per non conformità, che vanno da 3.000 a 90.000 euro a seconda della gravità dell’infrazione. La nuova legge si applica a 61 comuni di Barcellona.
In Francia esiste il concetto di “trève hivernale” (pausa invernale), grazie alla quale le espulsioni di un inquilino che non può pagare l’affitto sono sospese dal 1° novembre al 31 marzo. Il problema è lontano dall’essere risolto, ma almeno le famiglie non si ritrovano senza un tetto con le rigide temperature di queste zone.
energia
Uno dei problemi maggiori per un riutilizzo a breve termine degli alloggi disponibili sono le carenze gravi sotto il punto di vista energetico o strutturale. In alcuni casi gli alloggi, senza manutenzione da anni, non possono più essere qualificati come salubri.
Spesso sono proprio i nuclei con reddito basso a dover abitare questo tipo di alloggi, e si crea un doppio effetto negativo: da una parte una grande dispersione termica o energetica in un momento di grave crisi climatica, e dall’altro grandi costi per mantenere condizioni abitative decenti in casa (che possono rappresentare il 10% dell’intero reddito).
Si parla di povertà energetica quando vi è l’incapacità di mantenere i livelli dei servizi energetici in casa su un livello sufficiente, non potendo riscaldare e raffrescare la casa a causa di bollette energetiche eccessive, bassi redditi e scarsa efficienza energetica.
Quasi 50 milioni di persone sono affetti da povertà energetica nell’Unione Europea, circa il 10% della popolazione.
Da alcuni anni in Italia è stato introdotto l’A.P.E., l’Attestato di Prestazione Energetica (che ha sostituito l’Attestato di Certificazione Energetica, introdotto nel 2005) che documenta le caratteristiche energetiche degli immobili, e che ormai obbligatorio in caso di vendita o locazione.
L’A.P.E. prevede 10 classi : dalla migliore A4 alla G. Si stima che il 97% degli immobili italiani rientrano in una classe inferiore alle E.
Il 14 marzo 2023 il Parlamento UE ha approvato la proposta di direttiva europea EPBD per le Case Green con obiettivi di efficientamento energetico degli edifici. Anche se il testo deve essere ancora completato e approvato dal parlamento europeo, la direttiva prevede che, in caso di vendita, affitto o ristrutturazione, le unità residenziali debbano raggiungere la classe E entro il 2030 e la classe D entro il 2033.
Una serie di deroghe sono applicabili per gli immobili nei centri storici, i beni vincolati o con una potenziale perdita del valore architettonico, case ed edifici di culto, seconde case e unità indipendenti sotto i 50 mq.
La questione è spinosa, poiché una grande fetta del nostro patrimonio esistente sarebbe esclusa, a giusto titolo, da lavori di ristrutturazione che ne stravolgerebbero l’apparato di base. Allo stesso tempo, il settore dell’edilizia produce circa il 40% delle emissioni globali di carbonio e quasi un terzo di tutti i rifiuti. Sul consumo di suolo, il rapporto ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) del 2022 evidenzia come in Italia continuiamo a perdere 2 m² di suolo al secondo.
Una sensibilizzazione andrebbe fatta a tutti i professionisti della filiera edilizia per attivare buone pratiche nei vari contesti abitativi.
In Italia è stato istituito l’Ecobonus, che permette di avere sgravi fiscali qualora si apportino miglioramenti energetici all’edificio.
Il fondo di sviluppo urbano lituano, istituito nel 2009 per i condomini multi-appartamento, illustra il funzionamento pratico di un fondo rotativo. Il fondo offre prestiti agevolati a un tasso di interesse fisso (sovvenzionato) del 3%, con una scadenza massima di 20 anni, un periodo di grazia di due anni e una sovvenzione del 15% sotto forma di ammortamento per i risparmi energetici superiori al 20% e per il raggiungimento della classe D di efficienza energetica. È prevista una sovvenzione del 25% per livelli di risparmio superiori al 40%.
I sussidi vengono assegnati alle famiglie a basso reddito ammissibili alla ricezione di fondi statali. Anche le associazioni di proprietari di case possono usufruire dei prestiti agevolati e delle sovvenzioni erogate dal fondo e poi rimborsare i prestiti al fondo stesso. Le principali lezioni apprese sono state la necessità di avere associazioni di inquilini ben organizzate per utilizzare le sovvenzioni: la concessione di prestiti per singoli inquilini è infatti molto difficile da gestire.
Ciò contribuisce inoltre a rafforzare l’importanza delle strutture abitative “collettive” (cioè case popolari, pubbliche, cooperative e condomini) nella realizzazione rapida ed efficiente di ristrutturazioni su larga scala.
https://www.instagram.com/p/C088zb4C6bM/?img_index=2
L’Italia è il Paese che ha registrato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie OCSE. Alla fine del 2022, i salari reali nella Penisola erano calati del 7,5% rispetto al periodo precedente la pandemia contro una media OCSE del 2,2%.
Allo stesso tempo, un aumento generale dei prezzi non ha risparmiato la categoria degli immobili che sono sempre più cari ed inaccessibili per le famiglie a basso reddito.
Gli alloggi in edilizia pubblica sono sempre più spesso svenduti oppure restano indisponibili per mancanza di manutenzione.
Il diritto alla casa deve essere una delle prerogative per qualsiasi governo, per garantire il benessere dei propri cittadini, intesi come l’insieme delle persone che vivono sul territorio, e soprattutto per quelli che si trovano in situazioni più precarie.
e di queste zone.
Sosteniamo la campagna “Ma quale casa”, che ha lanciato una proposta di legge d’iniziativa popolare per inserire il diritto alla casa in Costituzione.
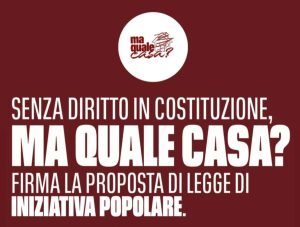
“Homeless”, il numero 14 di “Ossigeno”, la rivista di People, è interamente dedicato all’emergenza abitativa.
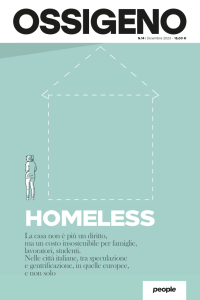
Domenica 29 giugno al Politicamp di Possibile abbiamo ospitato il panel
“Ma quale casa?”, il diritto all’abitare oggi — con Carlo Veneroni, Andrea Giuia, Alessandro Miglioli, Carlo Alberto Lentola
Politicamp 2023.
Emergenze, quelle vere: abitare, con Francesco Floris, Mattia Santarelli, Celeste Palermo